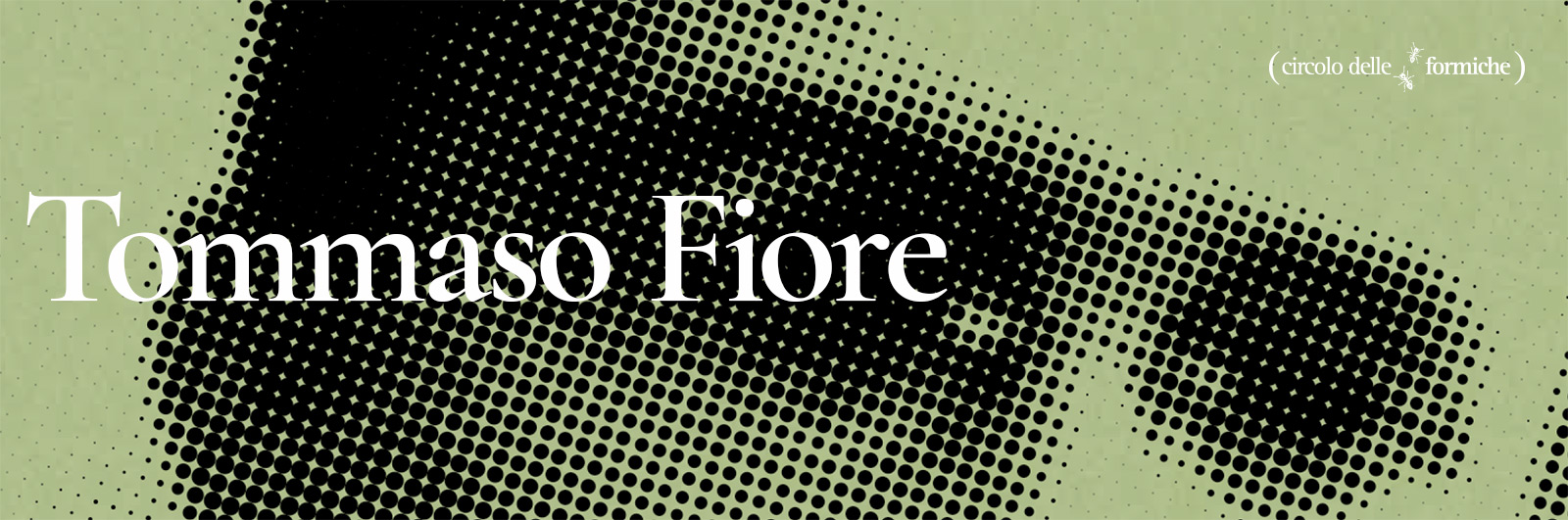FIORE E DOLCI: la coscienza civile mandava lettere
di Carlo Vulpio

Perché è utile, oggi, leggere una corrispondenza epistolare di una quarantina di lettere che due persone si sono scambiate tra il 1953 e il 1970? Per due motivi molto semplici. Il primo: «quei due»erano il grande meridionalista Tommaso Fiore e il grande pedagogo, sociologo e teorico della non violenza Danilo Dolci, quarant'anni più giovane di Fiore e tuttavia da questo apostrofato come «maestro», il secondo: il carteggio è un esempio di «concretezza» politica e culturale, merce ormai rara tra le nebbie e le mode del politicamente corretto.
L'epistolario de Il Professore e l'Architetto (Edizioni Libreria Dante & Descartes) è invece la ricostruzione inedita, curata da Giuseppe Dambrosio, di una partitura musicale, anzi di un vero e proprio inno, sul «concreto» agire politico e culturale vissuto in prima persona. Se per esempio in Sicilia - dove il triestino Dolci aveva scelto di vivere «concretamente» il suo essere cristiano e gandhiano e socialista umanitario - mancava l'acqua, la «concretezza» non poteva che consistere nel battersi per l'acqua, cioè per la costruzione di dighe che dissetassero campi e genti dell’sola e creassero lavoro. Come a Dolci riuscì di fare a Partinico, nel Trapanese, con la diga sul fiume Jato. Allo stesso modo, in Puglia, il socialista e professore di latino e greco Tommaso Fiore aveva agito «concretamente», prima diventando sindaco della sua città, Altamura, dal 1920 al 1922, poi finendo in carcere due volte, nel 1942 e 1943, per la sua tenace opposizione al regime fascista, e infine conducendo battaglie per il lavoro che tradusse in un libro sulle condizioni dei braccianti pugliesi, Il cafone all'inferno, del 1955: una delle più belle inchieste sociali dell'epoca (con Banditi a Orgosolo di Franco Cagnetta Campione e Banditi a Partinico dello stesso Dolci).
Fiore (Il Professore) e Dolci (l'Architetto, poiché aveva studiato al Politecnico di Milano) erano diversi. Il primo era una intelligenza vivida e razionale che aveva incantato Piero Gobetti e Carlo Rosselli. Il secondo è l'intelligenza energica e generosa fino alla spendita totale di sé, che incanta tutti da Piero Calaman-drei a Ernesto Balducci, fino ad Aldous Huxley, che definisce Dolci «un santo laico».
È Fiore a cercare per primo Dolci, non lo mollerà più, anzi lo seguirà passo dopo passo, quasi un tutore premuroso di consigli - che Dolci accetta con riconoscenza e un difensore strenuo, sia sul piano dell'azione politica, sia su quello della «giustizia ingiusta» che colpi Dolci due volte, nel 1964 e nel 1965. La prima, quando attuò il rivoluzionario «sciopero alla rovescia» con i contadini, assieme ai quali, contro il divieto delle autorità, sistemò una strada di campagna per raggiungere i luoghi di lavoro, La seconda, quando denunciò il sistema di voto mafioso nel Trapanese, sfidando
il ministro Bernardo Mattarella e il sottosegretario Calogero Volpe. Dolci venne denunciato dai due politici e perse la causa. Ma benché condannato a due anni di reclusione non andò in carcere, mentre per Mattarella la carriera politica fini lì, Aldo Moro lo escluse dal suo nuovo governo. Il pro-cesso a Dolci però fu uno scandalo, come e più del precedente sullo «sciopero alla rovescia», e fece infuriare il meglio dell'Italia della cultura e della politica (troppo lungo riportare qui l'elenco dei nomi) e in particolare Tommaso Fiore. Il quale sulla vicenda scrisse anche al segretario del Psi, Pietro Nenni, e alla sorella di Enrico Fermi, Maria Fermi Sacchetti. Lettere che Dambrosio ha opportunamente aggiunto al carteggio tra Fiore e Dolci.
«Le persone che debbono giudicare Dolci - scrive Fiore a Nenni – sono state scelte apposta per una condanna. Il capo del tre giudici dava l'impressione di quella debolezza che trova sempre buone ragioni nell'ordine dei superiori... un altro dei giudici era un minorato fisico, e il pm un ex prefetto del convitto nazionale di Palermo, oggetto di disprezzo e sberleffi da parte delle scolaresche per la sua pochezza d'ingegno». Nenni risponde amareggiato: «Si direbbe che un quadrato si costituisca attorno a ognuno dei magistrati e dei dirigenti della polizia e dell'Arma, che dimostrano la netta volontà di andare a fondo». Infatti. Così a Dolci, sulla vicenda, non resta altro che scrivere un libro, Chi gioca solo (Einaudi, 1966). Un volume strepitoso, sparito dalla circolazio-ne e mai più ristampato. Dimenticato, o meglio, rimosso. E che invece andrebbe riproposto e letto attentamente, se è vero, come scrive Fiore, che «Tu, carissimo Danilo, sei ormai una vocedell'umanità, della migliore umanità».
Corriere della Sera, 25 aprile 2025